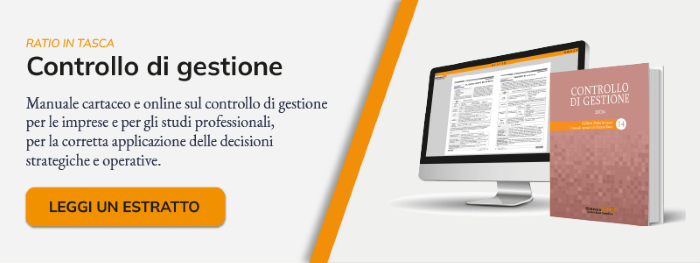Ford Kuga PHEV e fringe benefit 2025: il ruolo dei veicoli plug-in nelle flotte aziendali
Il 2025 ha introdotto un cambiamento significativo nella gestione delle auto aziendali a uso promiscuo. Con la Legge di Bilancio 2025, il sistema di tassazione dei fringe benefit è stato aggiornato con l’obiettivo di orientare la mobilità delle imprese verso soluzioni a basse emissioni.
L’impatto più rilevante riguarda le alimentazioni elettriche e ibride plug-in, che beneficiano di percentuali ridotte rispetto ai veicoli tradizionali. In particolare, per le ibride plug-in la tassazione è fissata al 20% del valore convenzionale, rendendo questa categoria particolarmente interessante per i fleet manager che cercano un equilibrio tra sostenibilità, contenimento dei costi e funzionalità operative. Il nuovo schema fiscale è entrato in vigore dal 1° luglio 2025, rafforzando un trend già in atto nella transizione energetica delle flotte aziendali.

Vantaggi per le flotte aziendali
Il ricorso a veicoli ibridi plug-in consente alle imprese di ottimizzare i costi complessivi legati alla gestione del parco auto e, allo stesso tempo, di mantenere elevati standard di servizio nei confronti dei propri dipendenti.
L’azienda trae vantaggio dalla deducibilità fino al 70% delle spese connesse alle auto assegnate a uso promiscuo, mentre la riduzione della base imponibile per il calcolo del fringe benefit rappresenta un vantaggio per il dipendente. È proprio il livello di emissioni del veicolo a determinare l’aliquota applicata al lavoratore.
L’adozione di tecnologie elettrificate, inoltre, permette di migliorare la sostenibilità ambientale dei processi interni e di contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni attesi nei prossimi anni. In questo contesto, i veicoli plug-in si posizionano come una soluzione versatile, efficace nelle percorrenze urbane in modalità elettrica e performante nei tragitti extraurbani grazie al supporto del motore termico.

Le caratteristiche della Ford Kuga PHEV in ottica fleet
All’interno dell’offerta plug-in destinata alle flotte, la Ford Kuga Plug-in Hybrid si distingue per alcune caratteristiche tecniche e funzionali che rispondono alle esigenze operative delle aziende. La sua autonomia elettrica consente di coprire gli spostamenti quotidiani con costi contenuti e un impatto ridotto sulle emissioni urbane. L’integrazione tra propulsione elettrica e termica permette inoltre di affrontare lunghe percorrenze senza vincoli infrastrutturali, garantendo continuità operativa anche a chi effettua frequenti trasferte.
In dettaglio, grazie alla batteria agli ioni di litio da 10,3 kWh utilizzabili, la Kuga Plug-in Hybrid consente di percorrere fino a 69 km in modalità elettrica nel ciclo combinato WLTP, un valore particolarmente utile nella guida quotidiana. In città, l’autonomia raggiunge fino a 89km nel ciclo urbano WLTP, favorendo una mobilità a zero emissioni locali nella maggior parte degli spostamenti ricorrenti.
La connettività avanzata, supportata da un sistema digitale evoluto, facilita la gestione delle attività lavorative e offre strumenti utili ai fleet manager per monitorare utilizzo ed efficienza. Le funzioni di assistenza alla guida, il comfort di bordo e la capacità di traino contribuiscono a rendere il modello adatto a un’ampia varietà di mission aziendali. In aggiunta, la possibilità di ricaricare tramite presa domestica o infrastrutture pubbliche aumenta la flessibilità operativa delle flotte distribuite sul territorio.
Grazie alla combinazione tra vantaggi fiscali sui fringe benefit, efficienza di utilizzo e tecnologie evolute, la Ford Kuga Plug-in Hybrid rappresenta una scelta vantaggiosa per le aziende che desiderano aggiornare il parco auto nel segno della sostenibilità e della riduzione dei costi complessivi.
Scopri di più su Kuga Plug-in Hybrid: https://www.ford.it/auto-ibride-elettriche/veicoli-ibridi-plug-in
Successione della conferitaria nei rapporti pendenti della conferente
Sullo specifico tema si deve rilevare come l’opinione dottrinale prevalente ritenga che il conferimento d’azienda, costituendo l’operazione una vicenda circolatoria dell’azienda stessa, comporti la successione di diritto, con l’eccezione del patto contrario, della conferitaria nei rapporti in itinere del soggetto conferente causalmente raccordati all’esercizio dell’impresa.
Contratti – Il subentro nei contratti da parte della società conferitaria trova il relativo supporto disciplinare nell’art. 2558 c.c. rubricato “Successione nei contratti”; la disposizione, nel comma 1, prevede che l’acquirente/conferitaria subentri nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente. Le parti sono ammesse a pattuire che alcuni contratti non partecipino alla cessione/conferimento, con esclusione di quei contratti indispensabili per l’esercizio dell’impresa, in quanto consolidati nel paradigma di universitas costituente l’azienda.
L’art. 2558, c. 2 c.c. prevede che il terzo contraente (contraente ceduto), che vede succedere la conferitaria alla conferente, può recedere dal contratto stipulato (a suo tempo) entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa, salvo la responsabilità del conferente. La giusta causa va causalmente raccordata alla sopravvenienza di circostanze che devono rendersi connotabili come rilevanti in quanto riferibili, ad esempio, ai cambiamenti nell’organizzazione aziendale dai quali può prospettarsi una diminuzione di efficienza operativa valutabile come non più idonea a consentire di conseguire il risultato contrattuale concordato.
Una particolare disciplina riguarda i rapporti di lavoro subordinato i quali, ai sensi dell’art. 2112 c.c., proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla conferitaria e i lavoratori conservano tutti i diritti inclusi quelli retributivi. I diritti economici derivanti dal contratto individuale a suo tempo stipulato con la conferente devono rimanere integralmente salvaguardati così da rispettare una condizione di assoluta continuità.
Crediti – In ordine al trasferimento dei crediti, pur registrandosi posizioni contrastanti, la giurisprudenza è concorde con l’opinione maggioritaria della dottrina che ritiene che il trasferimento del credito avvenga in automatico, salvo specifiche pattuizioni di esclusione. Eventuali garanzie personali prestate dal conferente non vengono meno restando, quindi, quest’ultimo vincolato al pagamento del debito originario.
L’art. 2559, c. 1 c.c. dispone che il trasferimento dei crediti relativi all’azienda ceduta (e quindi anche conferita), ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese; in ogni caso, il debitore è liberato se paga in buona fede il debito all’alienante (e quindi al conferente). Onde evitare che il debitore versi il saldo al conferente e vi possa essere il rischio che quest’ultimo non provveda a riversarlo alla conferitaria, è prassi, prima della registrazione dell’atto di conferimento, procedere con la comunicazione al debitore dell’avvenuto conferimento con l’invito a onorare il debito nei confronti della conferitaria.
Debiti – La disciplina relativa ai debiti dell’azienda ceduta/conferita trova supporto regolamentare nell’art. 2560 c.c. Tale disposizione nulla prevede circa il rapporto diretto tra cedente/conferente e acquirente/conferitaria dell’azienda, per cui il cedente/conferente conserva la responsabilità nei confronti dei creditori, salvo che questi ultimi non lo liberino espressamente dal relativo gravame, senza alcuna possibilità di deroga perseguibile con specifica clausola nell’atto di conferimento, la quale potrà solo sortire effetto nel rapporto interno tra conferente e conferitaria.
L’art. 2560 c.c. fa dipendere il coinvolgimento della conferitaria nelle obbligazioni verso i terzi solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori quali ad esempio dal libro giornale e il libro degli inventari, per cui, in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili, nonché per le imprese minori non tenutarie dei libri contabili, tale responsabilità solidale non è dilatabile all’acquirente/conferitaria. Al contrario dei crediti, i debiti, non si trasferiscono automaticamente dal conferente al conferitario, in quanto occorre che l’atto di conferimento lo preveda in modo esplicito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Rivista Ratio n. 12/2025.
Provvigioni di ingresso: concorrono al reddito CPB
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20.11.2025, n. 67/E ha chiarito che le provvigioni di ingresso attribuite al consulente finanziario per il cambio di preponente si qualificano come ricavi inerenti all’attività tipica dell’intermediario e, pertanto, devono concorrere alla determinazione del reddito concordato nel concordato preventivo biennale, essendo escluse dalle sterilizzazioni previste dall’art. 16 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13.
L’argomentazione poggia sulla natura funzionale delle provvigioni: sebbene talvolta condizionate a “target di raccolta e a vincoli pluriennali”, esse rappresentano “remunerazione ordinaria” dell’attività di promozione e collocamento svolta dal consulente abilitato all’offerta fuori sede, come previsto dall’art. 31 D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
Il ragionamento interpretativo si fonda sul principio “della tassatività delle esclusioni e delle variazioni di cui all’art. 16 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13”: le specifiche componenti elencate (plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive comprese le perdite su crediti, utili e perdite da partecipazioni, nonché la maggiorazione del costo del lavoro) incidono sul reddito concordato solo nei termini espressamente previsti dal legislatore e con le regole di determinazione proprie di ciascuna posta. Ne deriva che “non è ammessa un’estensione analogica dell’elenco a voci che, pur occasionali o non ricorrenti nella forma, risultino funzionalmente inerenti all’esercizio caratteristico dell’attività professionale”.
Contratto a termine per sostituzione in congedo: novità della Manovra
Il disegno di legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sul sistema di tutela della maternità e della paternità, rafforzando uno degli strumenti più rilevanti per la gestione organizzativa delle imprese: il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo parentale. La modifica si concentra sull’art. 4 D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), introducendo (se la misura verrà confermata) un nuovo c. 2-bis che amplia l’ambito temporale della sostituzione e consente un ulteriore periodo di affiancamento al rientro della persona in congedo.
Il D.Lgs. 151/2001 costituisce la fonte primaria in materia di congedi, permessi, riposi e sostegni economici connessi alla genitorialità. L’art. 4 del Testo unico rappresenta uno degli strumenti più operativi per le imprese, poiché autorizza il datore di lavoro ad assumere personale a termine in sostituzione del dipendente in congedo parentale, prevedendo una serie di facilitazioni organizzative ed economiche.
Il quadro normativo nel quale si inserisce la novità è articolato e, negli ultimi anni, ha subito una costante evoluzione. Infatti, prima il D.Lgs. 105/2022 e, successivamente, le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno gradualmente ampliato i periodi indennizzabili e introdotto misure di maggiore flessibilità, coerentemente con le politiche europee in materia di equilibrio vita-lavoro e promozione della parità di genere. Il D.D.L. di Bilancio 2026 prosegue su questa direttrice, potenziando ulteriormente il meccanismo della sostituzione a termine.
La novità del disegno di legge consente al datore di lavoro di prolungare il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del dipendente in congedo parentale per un periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore, purché entro il limite del primo anno di vita del bambino. Si introduce così una fase intermedia tra il rientro dalla sospensione e la piena riassunzione delle funzioni, finalizzata a facilitare la ripresa dell’attività lavorativa e, al contempo, a preservare la continuità organizzativa dell’impresa.
La ratio della norma è evidente: permettere un rientro graduale, non traumatico, che consenta alla persona genitrice di riallinearsi alle esigenze produttive senza sacrificare la conciliazione vita-lavoro. Il legislatore riconosce che il ritorno dal congedo rappresenta un momento particolarmente delicato, sia sul piano personale sia su quello professionale, e che un adeguato periodo di affiancamento può ridurre disallineamenti, sovraccarichi e rischi di inefficienza. Per l’azienda, la proroga del contratto di sostituzione offre un margine operativo aggiuntivo, consentendo di gestire il passaggio di consegne e verificare il riequilibrio dei carichi di lavoro senza pregiudicare la continuità delle attività.
La misura si colloca in un più ampio disegno volto a sostenere l’occupazione femminile, tutelare la genitorialità e favorire la parità di genere, ponendo l’accento su strumenti che non si limitano alla protezione economica, ma abbracciano l’organizzazione del lavoro nel suo complesso. L’introduzione del nuovo comma 2-bis, pur nella sua essenzialità, dimostra una crescente attenzione per le dinamiche di rientro dalla maternità e dalla paternità, spesso trascurate rispetto al periodo di astensione.
L’effettiva operatività della misura richiederà l’approvazione del disegno di legge e, verosimilmente, un coordinamento con la contrattazione collettiva, in particolare per le clausole relative ai periodi di sostituzione e ai modelli organizzativi adottati nei diversi settori produttivi. Resta inteso che il limite invalicabile stabilito dal legislatore è rappresentato dal primo anno di vita del bambino, che funge da perimetro temporale massimo entro il quale può operare il prolungamento del contratto a termine.
In conclusione, il D.D.L. di Bilancio 2026 aggiunge un tassello importante alla disciplina della genitorialità e alla gestione aziendale dei rientri dal congedo parentale, offrendo alle imprese uno strumento più flessibile e, al contempo, rafforzando le garanzie per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nella cura dei figli nel primo anno di vita.
Riforma Iva Terzo settore: ufficiale la proroga al 2036
La preannunciata proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle nuove norme Iva sul Terzo settore, approvata dal Governo il 20.11.2025, rappresenta una scelta che modifica il calendario di una riforma complessa e controversa. La normativa originaria, prevista dall’art. 5, c. 15-quater D.L. 146/2021, avrebbe imposto l’abbandono del regime di esclusione Iva per le operazioni verso soci e tesserati. Ora tutto slitta di 10 anni, una decisione che consente agli enti associativi di proseguire, almeno per ora, con regole note e più sostenibili. Una parte consistente del sistema si aspettava un rinvio, ma pochi immaginavano una dilazione così lunga.
È opportuno ricordare che il confronto con Bruxelles aveva portato a una procedura di infrazione, poiché la normativa italiana sulla decommercializzazione Iva risultava non pienamente allineata con la disciplina europea. La proroga non risolve il nodo interpretativo, ma lo sposta più avanti creando una finestra lunga che dovrebbe agevolare un coordinamento più maturo con il Codice del Terzo settore. Si consideri che la stessa Commissione aveva chiesto un’applicazione graduale, proprio per evitare l’impatto eccessivo su realtà che svolgono servizi sociali essenziali.
I software gestionali europei sposano l’AI
Il mercato europeo del software gestionale sta vivendo una fase di trasformazione rapida, con 2 player in particolare pronti a rafforzare la propria posizione: Visma e Xero. Entrambi puntano a offrire soluzioni più complete a imprese e professionisti, combinando compliance normativa e strumenti di automazione che semplificano il lavoro quotidiano.
Visma, multinazionale norvegese già presente in Italia, ha acquisito Alavie, società specializzata in consulenza su antiriciclaggio, privacy e 231. L’operazione segna un passo decisivo: l’obiettivo è integrare competenze verticali in materia di compliance direttamente nelle piattaforme digitali, così da offrire a studi professionali e imprese un pacchetto che unisce tecnologia e consulenza normativa. La scelta non è casuale: l’Italia è uno dei mercati più complessi sul fronte degli adempimenti e le aziende necessitano di strumenti che riducano il rischio di errori e sanzioni.
Operazioni straordinarie e Bonus Nuove Imprese
A decorrere dal mese di dicembre 2025 è data facoltà alle imprese di richiedere il cosiddetto “Bonus Nuove Imprese”, un incentivo di natura sperimentale destinato esclusivamente a quelle società costituite a seguito di operazioni straordinarie quali fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni, che abbiano aggregato un organico complessivo pari o superiore a 1.000 dipendenti.
Cos’è il Bonus Nuove Imprese – L’incentivo rappresenta una misura di natura contributiva, prevista dall’ambito normativo del cosiddetto decreto Aziende in crisi, successivamente convertito in legge, la quale consente ai datori di lavoro che costituiscono nuove entità imprenditoriali in seguito a operazioni societarie straordinarie di beneficiare di un esonero parziale o totale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fatta eccezione per i premi Inail, per un periodo massimo di 36 mesi. Lo scopo perseguito è il sostegno della formazione continua del personale e la garanzia della stabilità occupazionale.
Tfr, quali elementi entrano nel calcolo?
L’ordinanza della Cassazione 9.09.2025, n. 24849 ha qualificato come elemento retributivo il benefit dell’alloggio assegnato nei periodi di permanenza all’estero del lavoratore. Gli Ermellini hanno escluso la natura meramente riparatoria del benefit, che lo avrebbe qualificato come un rimborso spese conseguente a un onere che il dipendente ha sostenuto nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
L’operazione di qualificare il benefit e, in generale, le somme riconosciute al dipendente come retribuzione o, al contrario, rimborso spese, ha conseguenze dirette sul calcolo del Tfr.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Retribuzione utile per il calcolo del Tfr – La quota di trattamento di fine rapporto che il dipendente matura (art. 2120 c.c.) è il risultato della seguente operazione: retribuzione utile / 13,5 (coefficiente fisso) = Tfr lordo.
Nel paniere della retribuzione di riferimento rientrano le somme di competenza dell’intera annualità, da intendersi come quelle esposte nei cedolini paga relativi alle mensilità da gennaio a dicembre.
La retribuzione utile, a norma dell’art. 2120, c. 2 c.c. è rappresentata da tutti i compensi liquidi ed esigibili, anche se erogati successivamente per qualsiasi ragione, e costituita, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, da tutte le somme lorde corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura.
I contratti collettivi possono tuttavia derogare alle regole citate, ad esempio escludendo determinate voci retributive dal calcolo del Tfr. Come precisa il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello 3.10.2008, n. 43, se il contratto collettivo applicato in azienda o stipulato dall’organizzazione sindacale cui il datore di lavoro è iscritto specifica chiaramente quali elementi devono essere computati (e/o quali devono essere esclusi) il datore di lavoro deve rispettare tali criteri.
In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, si assumono a riferimento per il calcolo della retribuzione utile Tfr tutti gli emolumenti riguardanti eventi collegati al rapporto di lavoro o connessi alla particolare organizzazione del lavoro ovvero in diretta dipendenza con le mansioni svolte dal dipendente in azienda.
Somme escluse dal calcolo – Ai sensi dell’art. 2120 c.c. sono escluse dal calcolo del Tfr le somme occasionali, identificate dalla giurisprudenza consolidata di Cassazione come tutti quei compensi non direttamente ricollegabili alla prestazione lavorativa, ma che trovano nel rapporto di lavoro solo l’occasione per la loro erogazione. La scarsa frequenza dell’erogazione non è di per sé un valido motivo per determinare l’esclusione dal calcolo del Tfr. Possono essere considerati occasionali, per esempio, gli importi corrisposti unilateralmente dal datore di lavoro come liberalità, una tantum e premi, senza che ciò sia dovuto per effetto di un’obbligazione contrattuale.
Non sono invece somme occasionali (anche se erogate sporadicamente) i compensi per festività non godute e prestazioni straordinarie, essendo importi previsti da fonti contrattuali.
Somme legate alla prestazione lavorativa – A prescindere dalla frequenza di erogazione degli importi, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali che ne decretino l’esclusione dal calcolo del Tfr, sono da intendersi ricomprese le voci retributive riconosciute per le particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva e/o individuale. Si citano, a tal proposito, gli esempi delle maggiorazioni per lavoro festivo o notturno, le indennità di trasferta, nonché le indennità di sede e di cassa. Sono inoltre compresi nel calcolo del Tfr i compensi riconosciuti come retribuzione in natura.
Imprenditoria femminile 2025: bandi nazionali e regionali
Il quadro normativo del 2025 si articola in misure nazionali e regionali, caratterizzate da una combinazione di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e strumenti di garanzia che meritano un’analisi approfondita per coglierne appieno le potenzialità applicative.
Strumenti nazionali – Il programma ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero costituisce uno degli strumenti più versatili per supportare micro e piccole imprese con compagine prevalentemente o interamente femminile, indipendentemente dall’età delle socie. La misura finanzia progetti di investimento finalizzati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali o all’ampliamento, diversificazione e trasformazione di attività esistenti, attraverso una combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero che ottimizza la sostenibilità finanziaria dell’operazione.
Per le iniziative a vocazione tecnologica, Smart&Start Italia rappresenta lo strumento elettivo, offrendo finanziamenti compresi tra 100.000 e 1,5 milioni di euro a start-up innovative già costituite o in fase di costituzione. Particolarmente rilevante risulta lo stanziamento di 100 milioni di euro specificamente destinato a imprese guidate da donne, confermando l’operatività della misura per l’intero 2025.
Sul versante della garanzia, il Fondo Garanzia per le Pari Opportunità si configura come sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI, gestita dalla Presidenza del Consiglio tramite il Dipartimento per le pari opportunità. Questo strumento consente di accedere a condizioni agevolate di copertura del rischio sulle operazioni di finanziamento, risultando particolarmente utile per rafforzare la bancabilità di progetti imprenditoriali femminili e di attività professionali.
La misura Investimenti innovativi sostenuti da imprese femminili nei Comuni montani (IFIM) presenta caratteristiche di nicchia, ma di grande interesse per clienti operanti in specifici contesti territoriali. Riservata a start-up innovative costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali o cooperative con sede operativa in Comuni montani individuati da Invitalia, questa agevolazione intercetta una duplice finalità di sviluppo: l’innovazione tecnologica e la valorizzazione delle aree interne.
Il Fondo Impresa Femminile, gestito da Invitalia nell’ambito degli interventi PNRR, mantiene la sua centralità nella strategia di sostegno all’autoimprenditorialità femminile, con particolare attenzione agli ambiti scientifici e tecnologici. Il rifinanziamento garantisce la continuità operativa della misura, consentendo la presentazione di domande secondo le modalità definite dai bandi attuativi.
Dal 20.08.2025, il nuovo portale “Imprenditoria femminile” promosso da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Dipartimento per le Pari Opportunità rappresenta un punto di riferimento unificato per l’accesso alle informazioni relative agli strumenti di sostegno. Questo strumento digitale assume rilevanza anche per i professionisti, configurandosi come fonte aggiornata per la verifica delle opportunità disponibili e delle relative modalità di accesso, con particolare focus sui settori STEM e sulle professioni digitali.
Iniziative regionali – Il quadro regionale presenta una significativa eterogeneità, con alcune Regioni particolarmente attive nella promozione dell’imprenditoria femminile. Ad esempio, in Puglia, la misura NIDI – Nuove Iniziative d’Impresa 2021-2027 sostiene l’avvio di microimprese femminili attraverso contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero su investimenti fino a 150.000 euro. L’elemento distintivo risiede nella possibilità, per le imprese femminili virtuose, di trasformare fino al 75% del prestito in contributo non rimborsabile, con apertura dello sportello fino al 31.12.2030.
Alleghiamo poi un altra serie di proposte regionali.
Transazione e perdite su crediti: deducibilità con elementi oggettivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9.10.2025, n. 27096, è tornata ad affrontare il tema della deducibilità delle perdite su crediti conseguenti a transazione con il debitore, ambito da sempre delicato per la mancanza di indicazioni normative specifiche. La pronuncia offre l’occasione per riaffermare un principio consolidato: la perdita che scaturisce da una transazione può considerarsi deducibile quando è fondata su elementi certi e precisi, idonei a giustificare la scelta imprenditoriale di rinunciare, in tutto o in parte, al credito originario.
Il caso riguardava una verifica fiscale nei confronti di Alfa S.r.l., che aveva concluso una transazione con la propria debitrice Beta S.r.l., rinunciando parzialmente al credito e ricevendo, a saldo del residuo, la cessione di un ramo d’azienda. L’Amministrazione Finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità della perdita ritenendo insussistenti le ragioni economiche e ipotizzando un atto di liberalità, anche alla luce dei legami societari tra le 2 imprese. La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso di Alfa, ma la C.G.T. di secondo grado dell’Abruzzo riformava la decisione, riconoscendo la deducibilità della perdita in quanto conseguenza diretta e oggettiva della transazione, supportata dalla documentazione contabile e dal bilancio della debitrice.
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici regionali, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Richiamando i propri precedenti (tra cui Cass. nn. 10256/2013 e 10643/2018), i giudici di legittimità hanno ribadito che la transazione con il debitore costituisce un evento idoneo a generare una perdita deducibile, senza che sia necessario dimostrare l’insolvenza giudiziale del debitore. È sufficiente che la perdita sia supportata da fatti oggettivi e documentabili, tali da rendere ragionevole la decisione di transigere a condizioni meno favorevoli.
In tal senso, l’art. 101, c. 5 del Tuir collega la deducibilità delle perdite su crediti all’esistenza di elementi certi e precisi, che possono sussistere anche in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, inclusa la cancellazione del credito dal bilancio ai sensi dei principi contabili. Per i soggetti che adottano i principi OIC, la presunzione di certezza e precisione si considera integrata nei casi di cancellazione previsti dal documento OIC 15, secondo cui il credito viene eliminato dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari si estinguono o vengono trasferiti, insieme ai rischi e benefici connessi. Sebbene l’OIC 15, nell’appendice A, non menzioni espressamente la transazione tra i casi di cancellazione, essa rientra tra le ipotesi che comportano l’estinzione dei flussi finanziari relativi al credito, come riconosciuto anche da Assonime (circ. n. 18/2014). Lo stesso principio contabile, al paragrafo 26, include tra le perdite su crediti “realizzate” anche quelle derivanti da transazioni, confermandone la rilevanza contabile e fiscale.
La Corte ha quindi precisato che la valutazione sulla deducibilità deve fondarsi su dati oggettivi, come la situazione patrimoniale del debitore, documentata ad esempio attraverso il bilancio, che rendano comprensibile la scelta economica dell’imprenditore di definire la controversia con una rinuncia parziale. Non è invece necessario fornire prova di un’attivazione giudiziale per accertare l’insolvenza del debitore, purché la perdita risulti certa, precisa e correttamente contabilizzata.
Sul piano generale, resta fermo che la deducibilità di costi e oneri derivanti da accordi transattivi deve essere valutata anche alla luce del principio di inerenza. In giurisprudenza, si è riconosciuta la deducibilità di somme versate per transazioni dirette a prevenire contenziosi legati all’attività d’impresa, come nel caso delle banche che risarciscono clienti per disservizi (Cass. n. 28355/2019; interpello Ag. Entrate n. 491/2022). Diversamente, la Cassazione ha escluso la deducibilità di somme corrisposte per danni da comportamenti contra ius, estranei alla sfera imprenditoriale (Cass. n. 31930/2021).
In conclusione, l’ordinanza conferma che la transazione con il debitore, se sostenuta da elementi oggettivi e contabilmente documentata, consente la deduzione della perdita su crediti. Tale impostazione valorizza l’approccio sostanziale e razionale dell’imprenditore nella gestione del rischio creditizio, offrendo un quadro interpretativo ormai stabile e favorevole alla certezza fiscale.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing