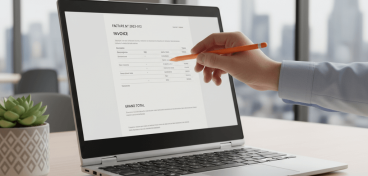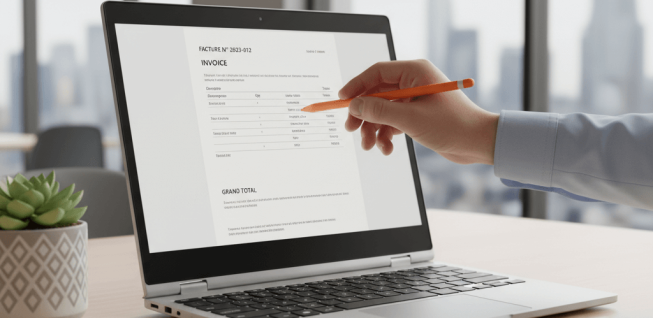Accertamento, riscossione e contenzioso
08 Luglio 2025
Costi presunti, vige l’obbligo di riconoscimento
Nel processo tributario qualora la ricostruzione sia basata su metodo “induttivo”, i costi vanno sempre stimati e detratti.
Nel delicato equilibrio tra potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria e diritto alla tassazione secondo capacità contributiva, l’ordinanza della Corte di Cassazione 25.06.2025, n. 17016 assume un valore dirimente in quanto impone che il giudice tributario ha l’obbligo giuridico, non una mera facoltà, di riconoscere i costi presunti quando si è in presenza di un accertamento “induttivo puro”.
Non si tratta solo di una regola prudenziale o di equità, ma di una conseguenza necessaria del principio costituzionale di cui all’art. 53 Cost., che impone che il prelievo tributario sia sempre proporzionato alla reale capacità economica. Se si presume un reddito, allora si deve presumere anche il costo che quel reddito ha necessariamente generato.
Nel caso concreto oggetto dell’ordinanza in commento, l’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito ricavi omettendo completamente i costi, per la mancanza di documentazione contabile.
I giudici tributari di merito, riconoscendo invece un’incidenza forfettaria degli oneri dell’80%, avevano drasticamente ridotto la base imponibile.
Nonostante il Fisco avesse impugnato la decisione, lamentando che, in assenza di prova documentale, non sarebbe possibile alcuna deduzione, la Corte di Cassazione ha respinto tali doglianze, affermando con nettezza un principio non derogabile secondo cui, in caso di accertamento induttivo, il giudice è vincolato a stimare anche i costi sulla base della natura dell’attività, degli usi di settore e di ogni altro elemento tecnico disponibile, anche mediante CTU.
Si sancisce un obbligo con impatto notevole e dirompente, in quanto si impone al giudice di ricostruire la situazione economica in modo completo, e non in modo parziale o strumentale. Un accertamento che prenda in esame solo la parte attiva (i ricavi) omettendo di considerare i costi, produce un’imposta su un reddito inesistente, ed è dunque incostituzionale. In ciò la pronuncia della Cassazione si appoggia sulla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 10/2023), secondo cui l’accertamento induttivo non può essere disancorato dal principio di proporzionalità, perché il tributo altrimenti diverrebbe sanzione.
Non si mette in discussione il fondamento normativo sancito dall’art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973. Ma, se da un lato, questa norma attribuisce un potere piuttosto ampio all’Ufficio (consentendo la ricostruzione “induttiva”), è l’art. 53 Cost. a imporre un argine: il limite è fissato nel senso che è necessario pur sempre ancorare l’imposizione alla concreta commisurazione con il reddito effettivo e non solo ai ricavi teorici.
E se il reddito effettivo non può essere ricostruito analiticamente, allora il giudice deve ricostruirlo presuntivamente, tenendo conto dei costi “fisiologici”, cioè di quei fattori produttivi che ogni attività imprenditoriale inevitabilmente sopporta.
Questo passaggio investe in pieno anche la responsabilità del difensore tributario, che in sede di ricorso è essenziale che rappresenti in maniera puntuale e argomentata l’incidenza percentuale dei costi, attraverso un’attenta analisi di settore (studi di settore, banche dati, coefficienti medi), documentando ed evidenziando quelli che sono i dati storici aziendali, ecc.).
Ecco perché, sul piano processuale, il ricorso avverso un accertamento induttivo puro non può limitarsi a contestare l’an o la misura dei ricavi presunti, ma deve necessariamente articolare una contronarrazione economica, fondata su criteri razionali di ricostruzione dei costi.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing