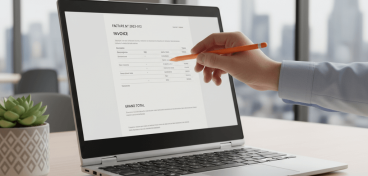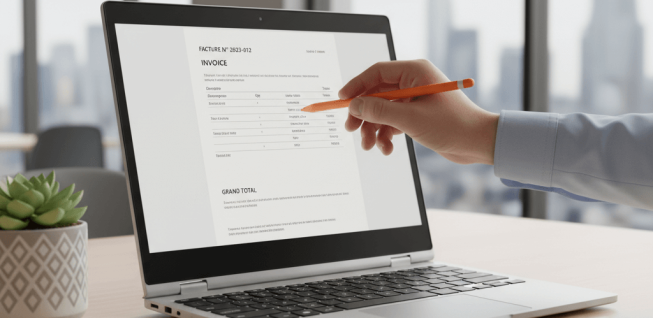Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Maggio 2025
CPB: gestione componenti straordinarie nel calcolo dell’imponibile
Il calcolo dell'imposta deve considerare elementi atipici realizzati nel biennio, non le variazioni fiscali ordinari.


Come noto, il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 13/2024, si fonda sul principio di cristallizzazione del carico fiscale stabilendo che l’imposizione avviene sempre sul reddito concordato, indipendentemente dal risultato effettivamente conseguito. Tale stabilità rappresenta indubbiamente un vantaggio significativo per il contribuente, garantendo certezza nella pianificazione fiscale per il biennio di efficacia dell’accordo. Nella prassi applicativa, tuttavia, emergono importanti sfumature che è opportuno considerare per una gestione ottimale dell’istituto.
Il legislatore, invero, ha operato una netta distinzione concettuale tra il reddito ordinario, oggetto dell’intesa con l’Amministrazione Finanziaria, e le ulteriori componenti che potrebbero manifestarsi durante il periodo concordatario, configurando un sistema di adeguamento che potremmo definire “parziale”. Si consideri, a tal proposito, quanto stabilito negli artt. 19, c. 1 e 30, c. 1 del decreto, che sanciscono il principio di invarianza dell’imposizione rispetto al reddito effettivo, sia esso maggiore o minore di quanto concordato, con alcune rilevanti eccezioni che analizzeremo.
La casistica comune evidenzia come, nell’esperienza applicativa, le componenti straordinarie richiedano un trattamento differenziato rispetto all’ordinaria gestione dell’attività. Difatti, l’art. 16, c. 2 D.Lgs. 13/2024 prevede espressamente che, durante la vigenza del concordato preventivo biennale, il calcolo dell’imponibile debba considerare il saldo tra elementi non prevedibili al momento della definizione dell’accordo. Nello specifico, concorrono a formare questo saldo elementi quali: plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, nonché utili e perdite derivanti da partecipazioni societarie. Tali componenti, proprio per la loro natura atipica e non ricorrente, modificano l’ammontare inizialmente stabilito, dando luogo a quella che tecnicamente viene definita “rinormalizzazione” del reddito concordato. La ragione di questa previsione è chiarita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2024, che sottolinea come tali voci rappresentino elementi non ordinariamente correlabili all’esercizio dell’attività caratteristica.
È importante e fondamentale notare che, come spesso accade nella normativa tributaria, l’elenco delle componenti straordinarie deve considerarsi tassativo. Vi rientrano anche i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali realizzati in costanza di concordato, aspetti talvolta trascurati nell’analisi dell’istituto.
Un caso particolare, meritevole di attenzione, riguarda le plusvalenze derivanti dall’acquisto di crediti da superbonus. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria con la circolare 23.06.2022 n. 23/E, il differenziale positivo che si genera quando un soggetto acquisisce crediti d’imposta a un valore inferiore rispetto a quello nominale costituisce un provento fiscalmente rilevante. Tale componente rientra a pieno titolo tra quelle che modificano il reddito concordato, richiedendo un’attenta gestione contabile e fiscale.
Nella pratica professionale si osserva che il processo di determinazione dell’imponibile effettivo non si esaurisce con la considerazione delle componenti straordinarie. Occorre infatti applicare un ulteriore meccanismo di riduzione, rappresentato dalle perdite fiscali pregresse, che operano secondo le regole generali contenute negli artt. 8 e 84 del Tuir. Al riguardo, è utile rammentare che permane il limite dell’80% dell’imponibile così determinato.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato restrittivamente questo aspetto, evidenziando la necessità di un approccio prudenziale nella gestione delle perdite fiscali in contesti concordatari. Un profilo di criticità ricorrente riguarda il trattamento delle agevolazioni fiscali. L’art. 35, c. 2 D.Lgs. 13/2024 (cfr. anche C.M. n. 18/E/2024) stabilisce che la spettanza di detrazioni, deduzioni e altri benefici fiscali viene determinata in base al reddito effettivamente conseguito e non a quello concordato. Questa precisazione appare coerente con la ratio dell’istituto, volto a garantire certezza sul carico impositivo senza però estendere automaticamente i vantaggi concordatari ad ambiti diversi. Si tratta di una regola che richiede un monitoraggio puntuale delle diverse componenti reddituali, al fine di assicurare la corretta fruizione di eventuali benefici fiscali.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing