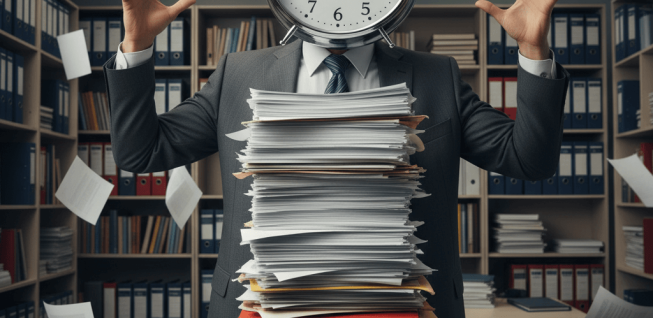Amministrazione e bilancio
08 Novembre 2025
Scorciatoia del 156 c.p.c. nelle notifiche
C’è un filo rosso che attraversa molte liti tributarie e che, a ben guardare, spiega perché alcuni contenziosi si trascinino più del dovuto e che riguarda l’uso disinvolto dell’art. 156 c.p.c. come argine o per chiudere falle che non dovrebbero aprirsi.


La tentazione è nota: la notifica è stata fatta male? Poco male si dirà, perché “lo scopo è stato comunque raggiunto”. Siamo al cospetto di una ricorrente scorciatoia retorica che all’apparenza semplifica, ma in realtà incrina 2 pilastri che risiedono nel diritto di difesa e nell’affidabilità della sequenza notificatoria.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ Sez. V, ord. 6.08.2025, n. 22709) ha richiamato tutti all’ordine, ricordando che la sanatoria non è un condono di stile, ma uno strumento eccezionale, applicabile solo quando l’atto viziato è stato davvero conosciuto, e non quando la sua esistenza è filtrata da un provvedimento successivo come un’intimazione di pagamento.
In linea di principio, “conoscenza mediata” non equivale a “conoscenza effettiva”.
La cornice normativa è semplice e per questo anche alquanto esigente. Per le persone giuridiche, la legge impone un percorso tassativo:
– prima il tentativo presso la sede legale;
– se non riesce, si passa alla residenza del legale rappresentante;
– solo in subordine si attivano gli strumenti per irreperibilità relativa o assoluta (artt. 140 e 143 c.p.c.), che restano comunque indirizzati alla persona fisica del rappresentante e non alla società in modo impersonale.
È una regola base, non un mero orpello. In pratica, la notifica “alla società” con deposito e affissione, senza passare dal rappresentante, salta le regole e produce un vizio che non è un semplice graffio formale.
La vicenda ricostruita nella pronuncia è paradigmatica: in primo grado, la Commissione ha correttamente riconosciuto l’inesistenza della notifica e della cartella perché eseguita “alla società” con le forme dell’art. 140 c.p.c., senza aver prima tentato sul rappresentante; in appello, la decisione è stata ribaltata facendo leva proprio sull’art. 156 c.p.c., con l’argomento che la società avrebbe comunque saputo dell’atto per effetto dell’intimazione. È su questo passaggio che la Cassazione è intervenuta con nettezza, stabilendo che l’ordine legale delle notifiche va rispettato e il “raggiungimento dello scopo” non si può invocare quando la conoscenza dell’atto viziato è solo riflessa, cioè mediata da un atto successivo. In pratica, la sanatoria non può trasformarsi in un alibi per chi ha saltato i passaggi obbligati.
La stessa conclusione vale anche quando entra in scena l’art. 60 D.P.R. 600/1973. Quel meccanismo, che consente il deposito in Casa comunale se nel Comune non si trovano abitazione, ufficio o azienda del contribuente, non scardina la sequenza del codice di rito ma al contrario, la presuppone.
Prima si verifica la sede, poi si cerca il rappresentante, e solo se anche questo canale è impraticabile si ricorre alle forme sostitutive. Ogni scorciatoia, dal deposito affrettato all’affissione impersonale, non impersona efficienza procedurale, ma integra una palese compressione del contraddittorio.
C’è poi un profilo di cultura giuridica che balza innanzi!
L’idea che “tanto alla fine l’atto lo hanno visto” risponde a un’ansia di efficienza che tutti comprendiamo, ma che non può prevalere sulla regola. Se la notifica è il ponte tra Amministrazione e contribuente, costruirlo con materiale di fortuna non è un risparmio: è un rischio per la tenuta del processo. E quando il processo inciampa su quel ponte, la colpa non è della formalità, ma della fretta con cui si è voluto accorciare il tragitto.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing